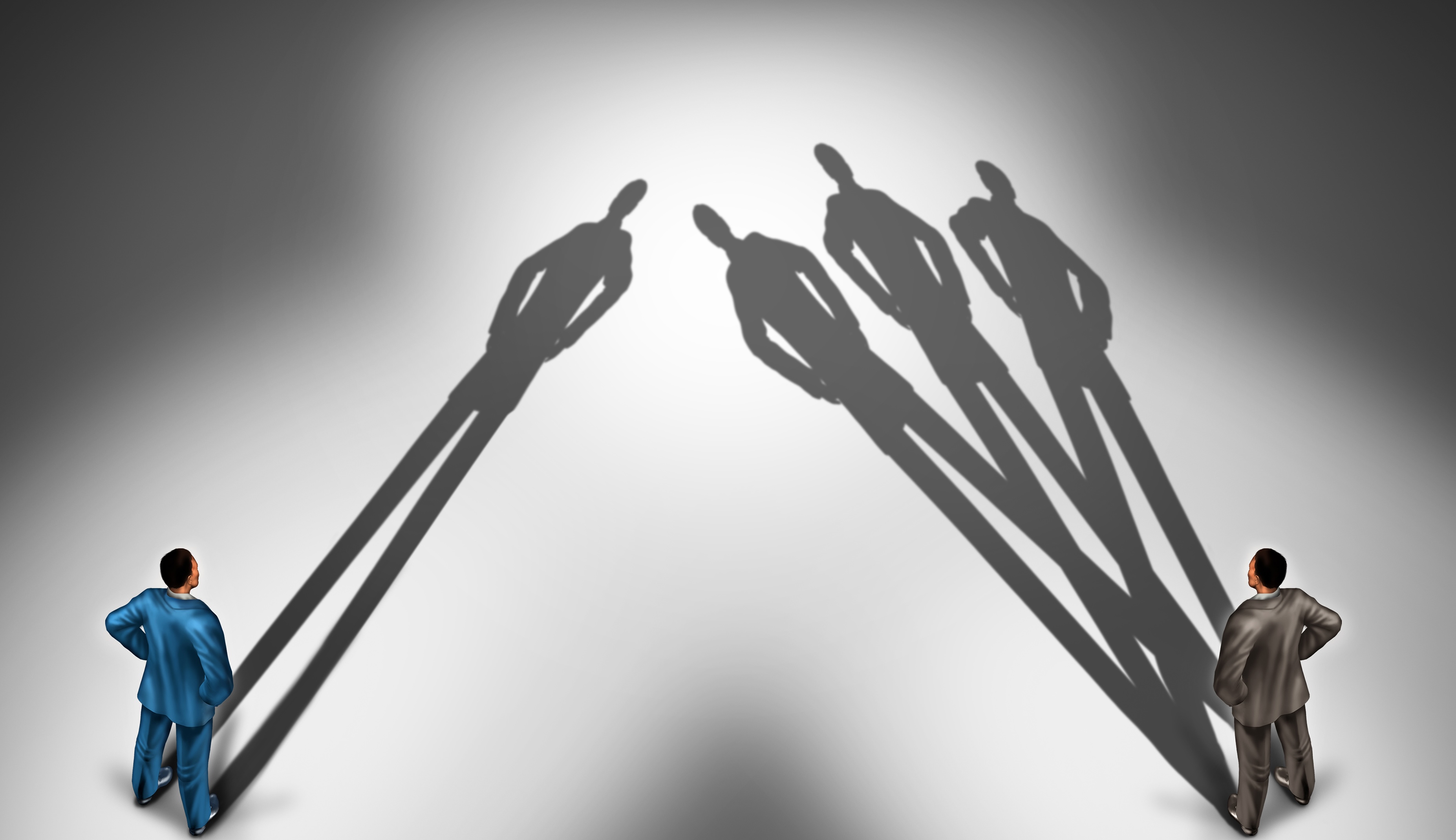Sarà capitato anche a voi di sentire la parola disruption, o una delle sue declinazioni come disruptive, e avere una sensazione di fastidioso dubbio. Ma cosa c’entra? E perché?
Il problema è che “disruption” è diventata una parola inflazionata: nel linguaggio di aziende e startup spesso diventa un modo sbrigativo per dire “novità”, “crescita”, “idea brillante”. In realtà, nella letteratura di management, la disruption ha un significato più preciso – e più scomodo.
Parola intraducibile in italiano disruption: interruzione, caos, scombussolamento secondo il Collins; interruzione, disgregazione secondo il Cambridge Dictionary. Ma nel linguaggio della tecnologia e del business c’è una componente intraducibile che, concettuale,emnte, si esprime nella “distruzione creativa”. Ma vediamo meglio i dettagli dopo.
La parola “disruption” è tornata di recente nelle cronache con l‘operazione Netflix–Warner Bros, che effettivamente segnala lo stravolgimento di un mercato, l’intrattenimento di massa, con il modello delle piattaforme streaming che ha cambiato le regole della filiera cambia la distribuzione (e, con essa, il potere contrattuale, i margini, la relazione con il pubblico).
Certamente la disruption portata dalle tecnologie digitali ha avuto negli ultimi decenni i suoi effetti sul valore delle imprese, ma quando ha davvero senso parlare di disruption e perché la parola non è sinonimo di innovazione? Ecco qualche promemoria e qualche riflessione sul buon uso della parola disruption.
Indice degli argomenti
Disruption, che cosa si intende nel mondo del business
Nel business, “disruption” indica un cambiamento capace di spostare valore e ridisegnare la concorrenza: cambia cosa i clienti comprano, da chi, con quale esperienza e con quali margini lungo la catena del valore.
Nella formulazione più nota (quella della disruptive innovation), la dinamica tipica parte “dal basso” o ai margini: un nuovo entrante attacca segmenti trascurati o crea un nuovo mercato con un’offerta inizialmente più semplice/accessibile (spesso anche “inferiore” secondo gli standard mainstream), poi migliora fino a conquistare la fascia centrale del mercato. Gli incumbent, nel frattempo, faticano a reagire perché sono incentivati a difendere i clienti più profittevoli con innovazioni “sostenitive”, non con rotture del modello.
In altre parole: la disruption non è “solo tecnologia”. È cambio di modello.
La parola “disruption” e i suoi significati
Sul piano linguistico, disruption rimanda a una “rottura”, a un’“interruzione” del corso normale delle cose: l’etimologia ricostruisce l’origine dal latino disrumpere (“rompere a pezzi”, “spezzare”). In italiano il termine è entrato come prestito e si è stabilizzato anche come neologismo, proprio perché funziona da scorciatoia per descrivere fenomeni che percepiamo come “di rottura” (dai mercati alla cultura pop).
Questo slittamento è interessante: dal significato “fisico” e generale (interrompere, spezzare) a quello manageriale (ribaltare un mercato), la parola assume un’aura quasi eroica.
È lì che nasce l’abuso.
Disruption, quando diventa la bandiera del digitale
L’uso moderno del concetto, nel lessico manageriale legato alla tecnologia, si consolida a metà anni Novanta. Il riferimento fondativo è l’articolo di Harvard Business Review “Disruptive Technologies: Catching the Wave” (1995), in cui Joseph L. Bower e Clayton M. Christensen mettono a fuoco un pattern ricorrente: aziende leader che falliscono non perché “dormono”, ma perché le loro logiche decisionali le portano a investire su ciò che i clienti migliori chiedono oggi, non su ciò che diventerà competitivo domani.
Pochi anni dopo, la teoria diventa pop grazie al libro “The Innovator’s Dilemma” del 1997, che porta la disruption fuori dalle aule e dentro i board (e, soprattutto, dentro la narrativa della Silicon Valley).
Da lì in avanti “disruption” diventa parola-bandiera del digitale: perfetta per descrivere la scalata di un modello che parte da nicchie o “non-consumatori” e poi risale. Ma proprio per questo, con il tempo, si presta a essere stirata fino a comprendere casi che non rientrano nella definizione.
Chi sono i teorici della disruption
Il concetto di disruption ha almeno due radici, spesso confuse (l’articolo di HBR del 2015 nasce proprio per tenerle separate…)
- Joseph Schumpeter e la “creative destruction”: l’idea che il capitalismo si muova per cicli in cui nuove combinazioni di innovazione distruggono assetti esistenti e ne creano di nuovi.
- Clayton Christensen e la “disruptive innovation”: la formalizzazione manageriale della disruption come dinamica competitiva (da qui il lessico “disruptive vs sustaining”).
Due casi di vera disruption
Per vedere la disruption “in purezza” conviene guardare a casi da manuale, in cui un’innovazione sposta la competizione più che alzare l’asticella prestazionale.
Un esempio classico è quello delle acciaierie mini-mill (stabilimento siderurgico di che nel dopoguerra hanno cominciato a utilizzare la tecnologia della fornace ad arco elettrico e rottami ferrosi come materia prima per la produzione in colata continua di acciaio. Ha il vantaggio rispetto ad un impianto standard con altoforno di essere molto più flessibile in particolar modo in periodi di sovrapproduzione o crisi del mercato). Partono con prodotti a basso valore (come il tondino per edilizia), poco interessanti per i grandi produttori “integrati”. Poi migliorano progressivamente, salgono di gamma e arrivano a erodere il cuore del mercato, fino a ribaltare gli equilibri dell’industria.
Nel digitale, Netflix è, invece, il caso più recente proprio perché mostra una disruption come traiettoria: prima cambia le regole della videoteca (catalogo, comodità, niente penali), poi ridefinisce la distribuzione con lo streaming e, infine, spinge la filiera a rinegoziare ruoli e potere contrattuale. Non è “solo” una piattaforma: è un modello che costringe gli incumbent a ripensare metriche, processi e catena del valore.
Come distinguere innovazione e disruption
La distinzione più pratica è questa: l’innovazione può essere enorme, ma resta innovazione se migliora ciò che esiste dentro le regole del gioco; la disruption è quando un prodotto o un impresa cambino le regole.
Per capirlo, invece di chiedersi “è una tecnologia nuova?”, conviene chiedersi:
- parte da un’offerta più semplice/accessibile che conquista non-consumatori o segmenti trascurati?
- sposta il modello di business (ricavi, canali, costi, metriche di successo), non solo il prodotto?
- risale verso il mainstream nel tempo, mentre i leader reagiscono tardi perché ottimizzati su clienti e margini attuali?
- ridisegna la filiera (chi controlla l’accesso al cliente, chi detta condizioni, dove si concentra il valore)?
Se queste condizioni ci sono, “disruption” è una parola sensata.
Se invece il vantaggio competitivo nasce soprattutto dal fare “meglio” (più premium, più performante, più efficiente) ciò che il mercato già valorizza, allora probabilmente siamo davanti a innovazione – anche radicale – ma non necessariamente disruption.
Che cosa leggere sulla disruption
Per approfondire il senso della disruption, ecco una selezione di letture di riferimento
Bower & Christensen, “Disruptive Technologies: Catching the Wave” (HBR, 1995)
Perché è rilevante: è il testo “fondativo” che descrive il pattern per cui le aziende leader perdono terreno non perché sono lente, ma perché i loro processi e incentivi le spingono a investire su ciò che chiede il core business, ignorando tecnologie inizialmente marginali.
Perché va letto: perché chiarisce il meccanismo organizzativo della disruption: come si decide cosa finanziare, perché certe innovazioni vengono scartate e quali scelte di governance possono evitare l’errore.
Frase takeaway: La disruption non nasce dall’assenza di competenze, ma da decisioni razionali prese con metriche sbagliate.
Christensen, “The Innovator’s Dilemma” (1997)
Perché è rilevante: è il libro che rende “pop” la teoria: spiega perché fare tutto correttamente (ascoltare i clienti migliori, aumentare la performance, difendere i margini) può comunque portare al declino quando il mercato cambia traiettoria.
Perché va letto: perché dà un frame mentale potente per leggere i segnali deboli e capire quando il vero rischio è strategico, non tecnologico.
Frase takeaway: Il dilemma è questo: le pratiche che ti rendono leader oggi possono renderti vulnerabile domani.
Christensen & Raynor, “The Innovator’s Solution” (2003)
Perché è rilevante: sposta la disruption dal “perché succede” al “come ci costruisci crescita”, traducendo la teoria in scelte di modello di business, segmentazione e organizzazione.
Perché va letto: perché aiuta a progettare innovazione in modo più ripetibile: cosa separare, dove investire, come evitare che l’organizzazione “immunizzi” le novità.
Frase takeaway: La disruption si governa: con struttura, incentivi e scelte di mercato coerenti, non con slogan.
Christensen, Raynor & McDonald, “What Is Disruptive Innovation?” (HBR, 2015)
Perché è rilevante: è il testo che “ripulisce” la teoria dagli abusi, distinguendo disruption da innovazione generica o semplice superiorità di prodotto.
Perché va letto: perché ti dà criteri pratici per non chiamare disruptive qualunque successo e per valutare correttamente competitor e startup.
Frase takeaway: Se non parte dai margini (o da nuovi mercati) e non risale nel tempo, spesso non è disruption: è solo innovazione forte.
Christensen Institute, risorse su teoria e casi (mini-mill, ecc.)
Perché è rilevante: è un archivio ben strutturato di definizioni, casi e distinzioni utili per applicare la teoria in modo coerente, con esempi ricorrenti come i mini-mill.
Perché va letto: perché è una “cassetta degli attrezzi” rapida: utile per chi fa strategia, open innovation e scouting e ha bisogno di esempi comparabili.
Frase takeaway: È la guida pratica per trasformare “disruption” da parola-moda a strumento di analisi.
Jill Lepore, “The Disruption Machine” (The New Yorker, 2014)
Perché è rilevante: è la critica più citata alla retorica della disruption: mette in discussione l’uso ideologico del concetto e l’idea che “disrupt” sia sempre e comunque una virtù.
Perché va letto: perché costringe a separare teoria, storytelling e interessi, evitando che “disruption” diventi un alibi per qualunque cambiamento o danno collaterale.
Frase takeaway: Prima di celebrare la disruption, chiediti chi crea valore, chi lo perde e con quali costi sociali e industriali.
Christensen et al., “Disruptive Innovation: An Intellectual History and Directions for Future Research” (Journal of Management Studies, 2018)
Perché è rilevante: ricostruisce l’evoluzione della teoria e mappa ciò che la ricerca supporta davvero, dove ci sono ambiguità e quali sono le direzioni future di studio.
Perché va letto: perché porta rigore: utile se vuoi usare “disruption” con precisione (in un articolo, una strategia, una ricerca) e non come etichetta generica.
Frase takeaway: La disruption è una teoria utile, ma va usata con confini chiari: altrimenti perde potere esplicativo.