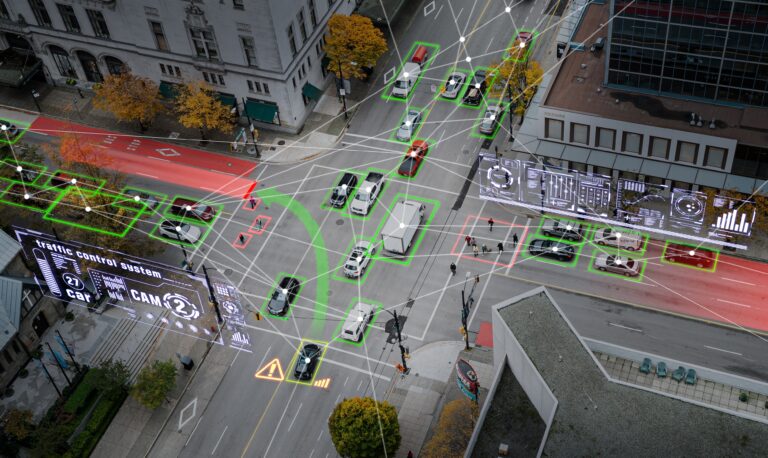Caro Direttore, non ho letto – e non so se leggerò – “The Open Organization” di Jim Whitehurst (CEO di Red Hat), ma ne ho letto con attenzione la ricca sintesi di Luciana Maci su EconomyUp. E voglio fare qualche commento critico sulle principali tesi di Whitehurst, forse perché invidioso delle oltre 42mila copie già vendute (il mio “Strategia” ne ha vendute solo 4.500).
È sufficiente il successo in un’impresa per parlare di nuovo paradigma strategico-organizzativo per il ventunesimo secolo?
Come spesso capita nel mondo statunitense, Jim Whitehurst – fiero di aver portato nei suoi 9 anni come CEO la Red Hat (fondata nel 1993 e operante nell’open-source software) a una capitalizzazione di Borsa di 12,5 miliardi di dollari – ritiene di aver trovato la nuova ricetta universale per gestire le imprese nel ventunesimo secolo. Che cosa dovrebbe dire allora Jeff Bezos, che ha fondato Amazon un anno dopo la nascita di Red Hat e l’ha portata a una capitalizzazione di oltre 350 miliardi? O Larry Page e Sergey Brin, che hanno fondato Google cinque anni dopo e l’hanno portata a una capitalizzazione (come Alphabet) di circa 550 miliardi?
È vero che le economie di scala non contano più?
“Le regole del gioco, che stabilivano chi vinceva e chi perdeva nel business, stanno cambiando. Le vecchie strategie standardizzate che si imparavano nelle business school, come le economie di scala, la scarsità e il vantaggio posizionale, non trovano più applicazione. Continuare a fare quello che facevano prima, limitandosi a spingere più forte sui pedali, non serve più. Qual è il nuovo modello organizzativo che conduce al successo?”, sostiene Whitehurst. Che le regole del gioco stiano cambiano profondamente, in un mondo dominato dai processi di digitalizzazione e di globalizzazione, è ormai una convinzione sempre più diffusa. Che le economie di scala rappresentino un concetto obsoleto mi sembra un’affermazione molto più azzardata: non solo per le imprese operanti nei comparti tradizionali, ma anche per quelle operanti alle frontiere dell’innovazione. La scala è stata sin dalla fondazione l’ossessione di Amazon, che per il suo conseguimento ha continuato a sacrificare i profitti. La scala è l’ossessione di Uber, che brucia ogni anno una quota significativa dei finanziamenti ricevuti (800 milioni di dollari nel 2016) per posizionarsi in nuove città del mondo. La scala è l’ossessione di Tesla, che – dopo il decollo nella fascia più alta del mercato – vuole diventare una grande dell’automobile e a questo scopo sta lanciando un nuovo modello a prezzo dimezzato rispetto ai precedenti e sta costruendo una gigafactory per la produzione di batterie, allo scopo di ridurne radicalmente il costo.

Attribuire un ruolo strategico determinante alla motivazione delle risorse umane rappresenta veramente una novità?
Il tema della motivazione delle risorse umane è tra i più antichi nella storia delle teorie organizzative, (falsamente) visto sin dai primi decenni del secolo scorso come contraltare al taylorismo e all’organizzazione fordista del lavoro. Periodicamente torna a galla, con un nome di volta in volta diverso: questa volta Open Organization, un titolo astuto che cerca di sfruttare il successo del termineOpen Innovation. Non mi stupisce che Hamel abbia firmato l’introduzione: perché insieme con Prahalad introdusse negli anni ’90 la nozione di stretch, per spiegare come imprese più piccole e con meno risorse, ma con grandi ambizioni condivise, fossero in grado di sconfiggere imprese più grandi e dotate di risorse molto più consistenti, ma con obiettivi conservativi e scarso entusiasmo.
L’enfasi sulla motivazione è estesa a tutte le risorse umane nelle imprese “digitali” di maggiore successo?
Non credo proprio che sia così. Ipersemplificando, mi sembra che le risorse umane vengano divise in due categorie: quelle che con la loro creatività rappresentano il vero punto di forza dell’impresa, coccolate e vezzeggiate in ogni modo per comprarne l’anima e per evitare che migrino verso altre imprese; quelle che viceversa svolgono mansioni ripetitive predefinite, spesso trattate con uno stile veterocapitalistico. È probabile che in Red Hat, una società come visto di softwaristi, sia largamente preponderante la prima categoria. Ma non è così ad esempio per Apple, che tiene all’interno del suo perimetro solo le risorse umane della prima categoria, mentre si avvale di fornitori in outsourcing (non certo teneri verso i loro dipendenti) per tutto ciò che riguarda la produzione fisica degli smartphone e degli altri suoi dispositivi. Non è così per Amazon, che riserva un trattamento completamente diverso per le due categorie che operano al suo interno: incentivi finanziari, sedi lussuose (come anche Apple) e forme articolate di smart working per la prima categoria; un inquadramento quasi militaresco per chi si occupa delle attività logistiche. Non è così per Uber, che per fare profitti e far contenti i clienti deve sacrificare gli autisti: che spesso peraltro, una volta entrati nell’organizzazione, ricorrono ai tribunali.