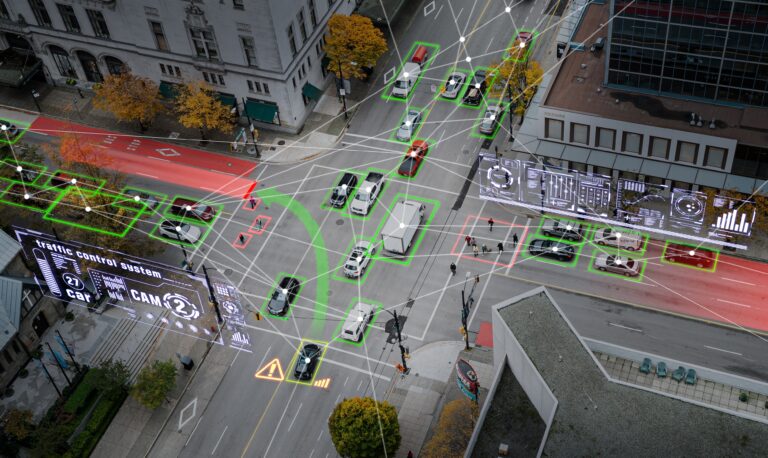Un uomo fuori dall’ordinario che ha condotto una vita fuori dall’ordinario, un pioniere che, alla fine degli anni Ottanta, ha convinto una grande azienda come Intel a fare qualcosa che non aveva mai fatto, investire in startup e imprese emergenti, ovvero a fare corporate venture capital: questo – e molto, molto altro – è Avram Miller, americano di origine ebraica che oggi vive in Italia, a Lecce, e che, a 80 anni, ha ancora l’entusiasmo, la creatività, l’intelletto e la voglia di fare di un ragazzo.
L’INTERVISTA
Avram Miller: “Da Intel Capital all’AI, la mia vita da agente del cambiamento”
Uomo d’affari, venture capitalist, scienziato, Avram Miller ha creato a fine anni ’80 Intel Capital, il CVC di Intel. Ora spiega a EconomyUp cosa pensa del VC, come sceglie le startup, i progetti futuri (uno con l’ITT di Genova). E perché un investitore può “rendere il mondo migliore”
Giornalista

Continua a leggere questo articolo
Argomenti
Canali
INNOVATION LEADER
-

Stefano Brandinali cambia ma resta nel pharma: da Chief Innovation Officer di Angelini a CIO di Chiesi
22 Gen 2026 -

Silvia Celani da Open Fiber a Head of Innovation della società di consulenza PNO Innovation
16 Gen 2026 -

Alessandro Braga (Veolia) racconta Research Gateway: l’innovazione che nasce dalla ricerca
07 Gen 2026 -

Enrico Pochettino (Iren): ecco perché nel deep tech servono pazienza e industria
29 Dic 2025 -

Come sviluppare l’innovazione in una media azienda: il caso Irinox
26 Dic 2025