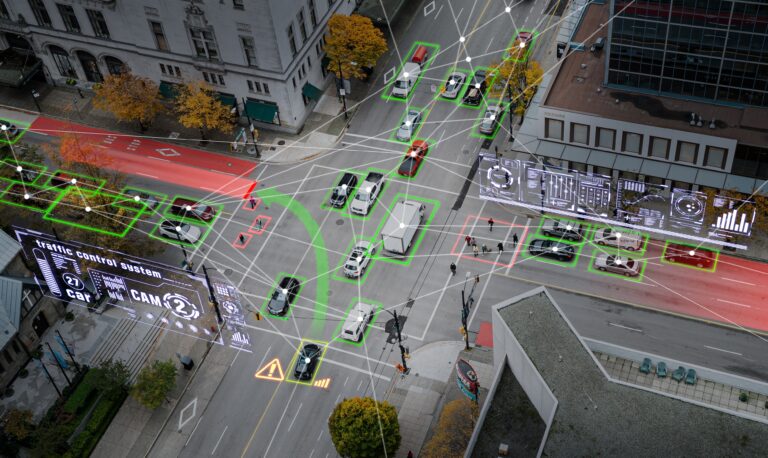Nel mercato globale non ci sono più confini e ragionare in termini nazionalistici è riduttivo e pericoloso. I capitali si muovono, le aziende vanno lì dove riescono ed è più conveniente. La globalizzazione è un fenomeno cominciato secoli fa con le grandi migrazioni e adesso sta vivendo un’accelerazione sul fronte economico mentre su altri (basti pensare alla nostra confusa Europa) è ancora in ritardo. Sarebbe sbagliato vivere i frequenti acquisti di aziende e marchi italiani da parte di gruppi internazionali come razzie condotte da stranieri “cattivi”. Anche le imprese italiane comprano all’estero ma di solito fanno meno rumore di quelle che vendono. Quindi, inutile piangere lacrime di coccodrillo ogni volta che una poltrona, una giacca o un gioiello cambiano bandiera.
Non c’è nulla di cui piangere a leggere i risultati di un’interessante ricerca svolta da Prometeia per conto di Ace, l’Agenzia per il commercio estero che un tempo fu Ice: “L’impatto delle acquisizioni dall’estero sulle performance delle imprese italiane”. In dieci anni sono state vendute 500 aziende del Made in Italy ma non è stata una “resa del sistema produttivo”, anzi. L’occupazione in quelle aziende è aumenta dal 2%, la produttività dell’1,4%, il fatturato addirittura del 2,8%. Non c’è stata perdita di valore, conclude Prometeia. L’ingresso di azionisti stranieri ha visto accrescere gli investimenti in ricerca e innovazione e ha quindi ridato slancio e competitività alle imprese.
Bene, quindi possiamo continuare a vendere senza alcuna preoccupazione? Dovremmo essere soddisfatti dal sapere che non abbiamo i capitali, le competenze, la visione per tenere in vita e far crescere le nostre migliori imprese? E, soprattutto, cosa sarà del nostro sistema socioeconomico fra 25-50-100 anni se coninueremo a passare la mano riservandoci solo di metterci le mani per tenere alta la bandiera della tradizione aritigianale che tutto il mondo ci invidia? Andrea Illy, che non è solo il numero uno della prestigiosa azienda del caffè ma guida anche Altagamma, l’associazione dei brand del lusso, sostiene che ad essere a rischio non è l’eccellenza produttiva italiana ma semmai il controllo societario delle aziende. Ha ragione, ad arrendersi sono gli imprenditori-padroni che non si sono preoccupati della manageralizzazione dell’impresa di famiglia e spesso neanche della successione. Hanno legato il loro destino a quello dell’azienda. E, anche quando hanno bei marchi e bei prodotti, finiscono male. Vendere resta l’unico modo per salvare l’azienda. Quando succede spesso però sì che diventa una resa. Certo non del sistema rpoduttivio ma di una classe imprenditoriale che ha rinunicato al suo ruolo trainante, rinunciando alla natura stessa dell’imprenditore: rischiare e investire.