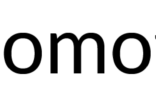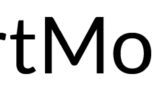“I veicoli elettrici o le auto a guida autonoma non contribuiscono realmente a una mobilità più sostenibile. La mobilità è davvero sostenibile quando smettiamo di costruire le città intorno alle automobili”. Così Jeff Speck, urbanista statunitense, autore e grande divulgatore della walkable city, spiega a EconomyUp la sua visione: il problema non è il mezzo in sé, ma l’impianto urbano che rende obbligatorio l’utilizzo dell’auto per ogni spostamento, “anche solo per andare a comprare il cibo per il gatto”.
Secondo Speck, molte città europee, soprattutto quelle storiche, hanno mantenuto un equilibrio più sano: hanno “messo l’auto al suo posto”, limitandone il predominio nei centri e puntando su alternative. Il confronto con gli Stati Uniti, dove la maggioranza delle persone vive in città medio-piccole cresciute secondo il paradigma automobilistico, rende evidente il nodo: quando la forma urbana è dispersa, la città smette di svolgere la sua funzione primaria, cioè avvicinare le cose.
Ma vediamo meglio chi è Jeff Speck, cosa ha progettato e cosa ha scritto, per poi passare a quello che ci ha raccontato.
Indice degli argomenti
Jeff Speck: l’ideatore della “Walkable City”
Urbanista, scrittore e docente statunitense, Speck è considerato uno dei massimi esperti internazionali di “walkability”, ovvero la progettazione delle città a misura di pedone. Nato a Belmont, nel Massachusetts, nel 1964, ha studiato arte e architettura al Williams College e ha conseguito un Master in Architettura ad Harvard.
La sua carriera è iniziata nello studio Duany Plater-Zyberk & Co., dove ha lavorato come Direttore del Town Planning e ha contribuito alla diffusione del movimento del New Urbanism, nato negli Stati Uniti negli anni ’80 e ’90 come reazione alla crescita disordinata delle periferie (urban sprawl) e alla dipendenza dall’automobile. Dal 2003 al 2007 è stato Direttore del Design al National Endowment for the Arts, dove ha guidato programmi innovativi come il Mayors’ Institute on City Design e il Governors’ Institute on Community Design.
Nel 2007 ha fondato Speck & Associates, oggi Speck Dempsey, studio con sede a Brookline che sviluppa masterplan, studi di mobilità urbana e piani di rigenerazione per amministrazioni e investitori privati. Tra i progetti più significativi figurano il “Project 180” a Oklahoma City, la trasformazione del Monon Boulevard a Carmel in Indiana (foto sotto) e il riassetto urbano di Tampa.

Parallelamente all’attività professionale, Speck ha avuto un impatto rilevante anche come autore. Ha firmato testi ormai di riferimento come Suburban Nation, The Smart Growth Manual, Walkable City e Walkable City Rules. In particolare, Walkable City è diventato un bestseller internazionale ed è stato tradotto in più lingue, consolidando la sua reputazione come uno dei principali teorici della mobilità sostenibile.
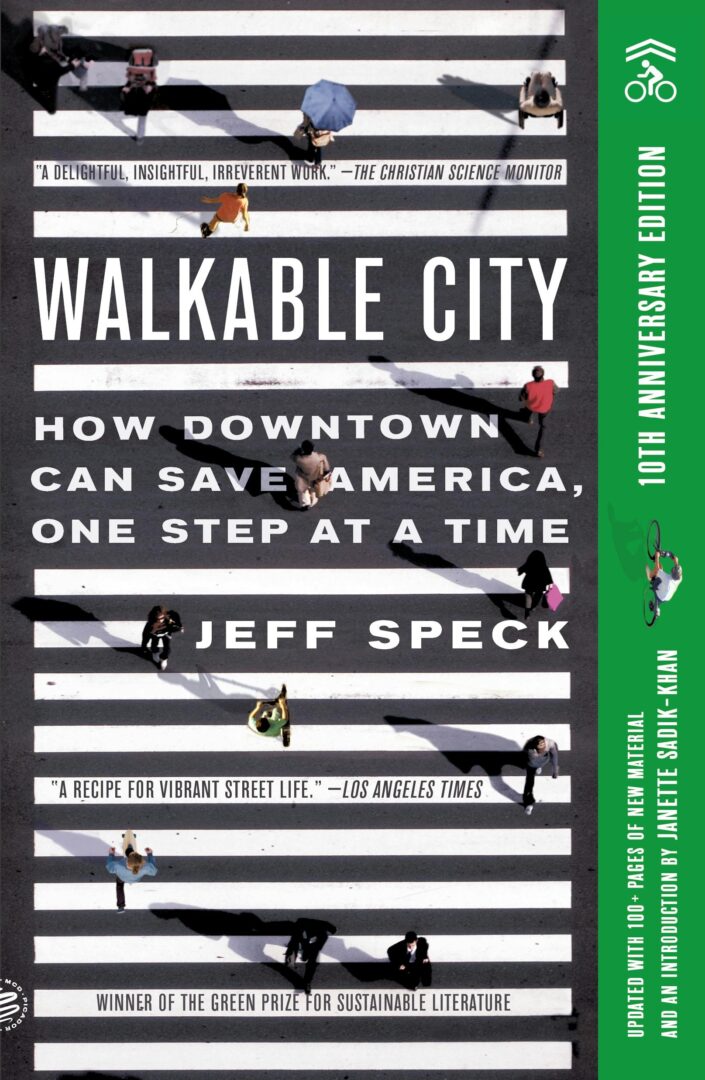
Oggi Jeff Speck vive a Boston e continua a diffondere la sua visione attraverso conferenze, TED Talks e consulenze a livello globale, promuovendo città più vivibili, sostenibili e orientate alle persone.
L’auto elettrica è davvero più sostenibile?
Abbiamo deciso di iniziare l’intervista partendo da quella che molti, se non quasi tutti, ritengono un simbolo della mobilità sostenibile: la mobilità elettrica.
Lei dice che non basta. Perché?
Ci tengo a premettere: a mio parere dovremmo tutti avere un’auto elettrica, perché è giusto smettere di fare affidamento sui combustibili fossili e queste vetture sono teoricamente più sostenibili delle auto a benzina. Dico “teoricamente” perché il saldo ambientale diventa positivo solo nel lungo periodo. In particolare la fabbricazione della batteria comporta un consumo di energia maggiore rispetto a quello di un’auto a benzina. Inoltre, almeno negli USA, le vetture elettriche sono diventate una scusa per costruire veicoli più grandi, più pesanti e più veloci: spesso pesano il doppio delle auto a benzina che sostituiscono, vanificando parte dei benefici. Un veicolo più pesante è infatti anche più pericoloso in caso di incidenti. Poi hanno freni e pneumatici più grandi. E circa l’85–90% del particolato che respiriamo, legato alle auto, proviene proprio da pneumatici e freni, non dallo scarico. Considerando tutti questi elementi, l’impatto complessivo delle elettriche sulla sostenibilità è limitato. E non cambia la struttura delle nostre città attorno all’auto. Il problema non è il carburante, ma il fatto che l’auto sia necessaria per qualsiasi spostamento e che la pianificazione centrata sull’automobile generi dispersione urbana: più chilometri di strade, di reti elettriche, di fognature e di acquedotti, insieme a case sempre più grandi costruite solo perché c’è spazio per espandersi
Vale lo stesso per l’auto a guida autonoma?
Direi proprio di sì. C’è entusiasmo perché si pensa che l’uso di questi veicoli potrebbe ridurre o eliminare la proprietà dell’auto. A suo tempo si disse la stessa cosa di Uber, che prometteva di “salvare il pianeta” limitando l’uso dell’auto. Gli studi mostrano che non è andata così. Anzi, in molti Paesi in via di sviluppo, le persone comprano autovetture solo per diventare autisti di Uber. L’auto autonoma è, in sostanza, un Uber senza conducente, ma più economico, perché non paghi il driver. Rendere la guida più economica rafforza la suburbanizzazione. Se puoi lavorare in auto, il vincolo principale, cioè il tempo perso nel traffico, si attenua, e le persone saranno disposte a vivere più lontano dal lavoro, allungando i tragitti. A parità di altri costi (negli USA la benzina costa meno che in Europa), il “prezzo” che paghiamo per guidare è il tempo sprecato nel traffico. Quando i veicoli autonomi rendono quel tempo produttivo, la gente guiderà di più. Aumenterà l’uso dell’auto, non necessariamente la proprietà.
Come l’avvento dell’automobile ha cambiato le città
Il problema viene da lontano, vale la pena ripercorrerlo con un breve excursus. Qual è stato l’impatto dell’utilizzo di massa delle automobili sui centri urbani?
L’impatto maggiore dell’automobile è stato quello di spezzare la logica “nodale” dei trasporti. Prima dell’auto, infatti, i sistemi di mobilità creavano concentrazioni di attività: i porti per le navi, i centri ferroviari, le linee dei tram. Negli Stati Uniti, a metà del Novecento, praticamente ogni città con più di 10.000 abitanti aveva un sistema tranviario. Quasi tutti furono smantellati con l’avvento e la “celebrazione” dell’automobile. Il tram, lineare e con fermate frequenti, generava una sequenza di nodi ravvicinati che differenziava il paesaggio in zone a maggiore e minore densità. L’auto, al contrario, ha reso tutto equivalente: un semplice nastro d’asfalto può rendere qualsiasi luogo accessibile tanto quanto un altro. La perdita di questa qualità nodale ha favorito la dispersione urbana, aggravata da un altro fattore: la zonizzazione mono-funzionale, ovvero la destinazione di intere aree a un solo uso.
Un quartiere fatto solo di abitazioni potrà mai essere una vera comunità?
No. Un’area commerciale resta deserta di notte, i parchi direzionali si svuotano alle 18.00, trasformandosi in “zone morte”. I modernisti del primo Novecento, ispirati da architetti europei, diffusero questo modello. Il momento decisivo fu la Fiera Mondiale del 1939: nel padiglione General Motors l’industrial designer Norman Bel Geddes presentò “Futurama”, un futuro fatto di torri e autostrade separate. Sul muro campeggiava la frase: «Le aree residenziali, commerciali e industriali sono state separate per maggiore efficienza e convenienza». Ma che convenienza c’è nel dormire in una parte della città, lavorare in un’altra, mandare i figli a scuola in una terza?
Quella visione, resa possibile dall’automobile e dall’idea di un’economia costruita sull’uso obbligatorio dell’auto, ha dominato per decenni. Solo ora se ne stanno vedendo i limiti. Negli Stati Uniti si è affermato il modello del “central business district”: downtown trasformati in aree di soli uffici, con qualche servizio a supporto. Negli anni Sessanta, Jane Jacobs ribaltò quell’impostazione con il suo celebre libro The Death and Life of Great American Cities, ancora oggi il testo di urbanistica più letto negli USA. Giornalista senza formazione accademica, Jacobs osservò la città dal basso, studiando cosa rende vivibili i quartieri. Notò, ad esempio, che Wall Street attirava ogni giorno 400.000 lavoratori ma non aveva né ristoranti né palestre di qualità: mancava quella che lei chiamava “diffusione temporale”, cioè attività sia di giorno sia di sera. Senza questa continuità, un luogo non può essere davvero vitale. Jacobs sosteneva che «non si possono invitare le persone in centro, bisogna portarcele».
Nello stesso periodo, però, negli Stati Uniti prendeva piede l’idea di portare le autostrade nei centri urbani, per renderli “più accessibili” a chi viveva in periferia.
In realtà, le autostrade hanno reso più facile abbandonare i centri. L’aver abbracciato l’auto come mezzo quasi esclusivo, la pianificazione intorno ad essa e la zonizzazione mono-funzionale sono stati i tre fattori chiave del declino urbano. Il più grande investimento infrastrutturale nella storia degli Stati Uniti, il sistema autostradale, era stato concepito per restare fuori dalle città, ma molti sindaci lo vollero nei downtown per avere posti di lavoro. Il risultato è che la tipica città americana si è ritrovata tagliata in due da autostrade che attraversavano soprattutto i quartieri delle minoranze: afroamericani, ebrei, immigrati. Una devastazione sociale ampiamente documentata.
La lezione di Jane Jacobs resta valida: riportare le abitazioni nei centri. Più residenti significa più vita urbana, non solo di giorno ma anche di sera. Ed è questa vitalità che rende una città sana e sostenibile.
Smart city: gli errori degli Usa da non ripetere in Italia
A proposito di città sostenibili: lei ama l’Italia e ha vissuto per un periodo a Firenze. Cosa ha osservato? Cosa suggerirebbe per migliore la sostenibilità dei nostri centri?
Prima di tutto, non sono certo di avere molto da insegnare alle città e agli urbanisti italiani: il modo in cui i vostri centri si sono sviluppati nel tempo è, in generale, molto più equilibrato rispetto a quanto accaduto da noi. Quando partecipo a eventi nel mondo, soprattutto in Europa e ancora di più nei Paesi in via di sviluppo del Sud America, ho spesso un obiettivo: raccontare gli errori commessi negli Stati Uniti.
Negli USA lavoro soprattutto in città di medie dimensioni. Metropoli come Los Angeles, San Francisco, New York o Boston dispongono di team di pianificazione solidi e ben integrati nella governance urbana, ma la maggior parte delle città americane non ha queste risorse. Centri più piccoli e meno noti, come Memphis, Louisville o Chattanooga, rappresentano il contesto in cui vive la maggioranza degli americani. È proprio qui che si concentra gran parte del mio lavoro, perché queste città non hanno accesso alle migliori pratiche, alle tecniche più avanzate e ai professionisti più qualificati della pianificazione urbana.
Per evitare di ripetere l’esperimento fallito della suburbia americana, il messaggio principale che posso trasmettere alle città italiane è lo stesso indicato da Jan Gehl, il celebre urbanista danese autore di “Cities for People” e responsabile della grande area pedonale di Copenaghen. Gehl, che ha lavorato in tutto il mondo ed è profondo conoscitore della realtà europea, afferma che nel XX e XXI secolo le automobili si sono diffuse “come l’acqua”: le città che ne hanno accolte di più hanno continuato a esserne invase, mentre quelle che ne hanno accolte di meno hanno mantenuto livelli più contenuti. Il risultato è che le città con più automobili oggi sono meno robuste, meno vivibili, meno resilienti, più inquinate e meno sostenibili rispetto a quelle europee che hanno scelto di limitarne l’uso.
Oltre a Copenhagen, ha in mente altri esempi virtuosi di città europee impegnate per la mobilità sostenibile?
Parigi è un esempio emblematico: l’amministrazione ha eliminato migliaia di posti auto per costruire una rete ciclabile estesa e funzionale, aperta a biciclette, monopattini e altri mezzi alternativi all’auto. Un approccio simile è stato adottato anche a Londra, in Germania e, da molti anni, nei Paesi nordici, che guidano la transizione da una mobilità centrata sull’automobile a una basata prevalentemente sulla micromobilità. Nella già citata Copenaghen, ad esempio, sette cittadini su dieci si recano al lavoro o a scuola a piedi o in bicicletta. Negli Stati Uniti, invece, questa percentuale è minima.
Cos’è una Smart City secondo Jeff Speck
Soffermiamoci sul termine “smart city”. Ci si interroga da anni sull’appropriatezza di questa definizione, per esempio l‘urbanista Carlo Ratti preferisce parlare di “Senseable City”. Lei cosa ne pensa?
Il termine “smart city” può essere “scintillante”, “shiny”. Credo nei vantaggi delle tecnologie: ad esempio, cestini che segnalano quando sono pieni e camion dei rifiuti che vengono indirizzati a svuotare solo quelli effettivamente necessari, rendendo il servizio più efficiente. Tuttavia, in una prospettiva più ampia, alla luce dei successi e dei fallimenti delle città americane rispetto a quelle europee, una città sostenibile, sana, produttiva e resiliente è, lo ripeto, soprattutto quella che ha scelto di non affidarsi all’automobile come principale mezzo di trasporto.
Già negli anni Quaranta l’urbanista Lewis Mumford avvertiva che “il diritto di portare un’automobile a ogni indirizzo di una città equivale al diritto di distruggere la città stessa”. È esattamente ciò che è accaduto in gran parte dell’America: molte città non sono più pedonali né piacevoli da vivere.
Da appassionato di auto – ho sempre desiderato una Ferrari, e resta la mia preferita – ho riconosciuto con difficoltà che il principale errore della pianificazione urbana americana è stato l’eccessivo affidamento sull’automobile. Al contrario, in molte città europee l’auto è stata relegata a un ruolo secondario: i centri storici non sono pensati per grandi flussi di traffico e le periferie sono più orientate al trasporto pubblico che all’uso dell’auto privata. Questo rende spesso difficile possedere e utilizzare un’auto, ma costituisce anche un importante punto di forza per la vivibilità urbana.

Quindi cosa fare concretamente per trasformare una città in una smart city?
Il mio approccio alla smart city si basa su due regole: portare la densità dove c’è trasporto pubblico frequente e, viceversa, progettare nuove linee per servire le aree più dense. Da qui l’importanza di avere più piste ciclabili e più trasporto pubblico.
(Sotto Jeff Speck, Courtesy Gary Higgins / Boston Business Journal)

Il caso Milano: come lo vede Jeff Speck
A Milano è stata aperta nei mesi scorsi un’inchiesta sull’urbanistica: presunti abusi commessi da persone che lavorano nell’amministrazione (costruttori, architetti e progettisti) per autorizzare e accelerare la costruzione di nuovi palazzi. Cosa ne pensa come urbanista?
Non conosco a fondo la realtà milanese, anche se ho visitato il Bosco Verticale, che considero un complesso straordinario. Tuttavia, lo definirei un esempio di “sostenibilità performativa”: appare sostenibile perché ricoperto di verde, ma in realtà resta un grande edificio in cemento, con un elevato impatto energetico incorporato. Al di là dei casi specifici, un buon piano urbanistico deve tenere conto di tutti gli aspetti della vita quotidiana, e parchi e spazi ricreativi ne sono parte essenziale. Ma ricordo che, di fronte al Bosco Verticale, c’è un bel parco frequentato dagli abitanti locali, oltre che dai turisti come me. Ed è un bene, perché quartieri composti soltanto da edifici e strade risultano incompleti.
Detto questo, bisogna sottolineare che alcune delle città più piacevoli al mondo vivono anche di spazi pubblici molto piccoli e intimi: non è la grandezza a determinare la qualità, anzi spesso sono proprio gli spazi ridotti a rivelarsi più accoglienti. Come sottolinea Jan Gehl, quando si parla di spazio pubblico, “togliere qualche metro” può renderlo più vivibile. Una città non è completa senza parchi e aree ricreative in ogni quartiere. E, soprattutto, una città pedonale non può costringere i cittadini a prendere un mezzo di trasporto per raggiungere un’area verde.
A quale prezzo si costruisce la modernità in una città? Gli affari rallentano se si dà spazio al verde?
Direi che cercare la modernità per se stessa non è produttivo. Cerchiamo di risolvere problemi: se la soluzione porta qualcosa di nuovo e “moderno”, bene. Ma non dovremmo aspirare a essere moderni per il solo gusto di esserlo.